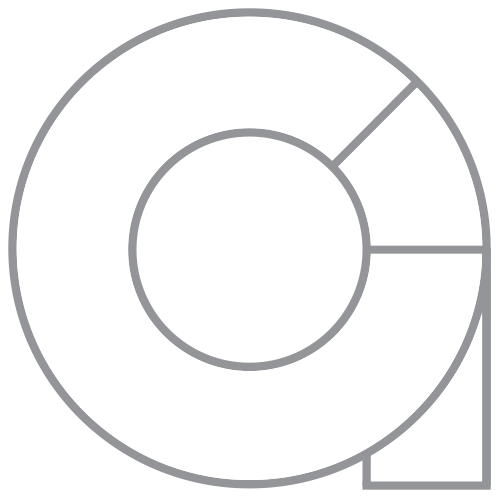Roberto Daolio, Ad’a, 2008
Catalogo Area d’azione, Imola, 2008
Tutto cambia e si muove. Non vuole essere certamente una considerazione originale. Tuttavia a volte si avverte la necessità di ribadirlo e di sottolinearlo. Anche per il semplice motivo che l’abitudine crea assuefazione e altrettanto spesso la ritualità induce alla ripetizione priva di scarto e di differenze. E soprattutto vanifica e sfuma l’impegno a sottrarre a ogni forma di stereotipizzazione o di indulgenza la memoria.
Di uno spazio, di un luogo, di un progetto entro cui ricombinare e riaggregare frammenti di mondo e di realtà attraverso il fare e il sapere contemporanei dell’arte e degli artisti (Poiesis). Il concept di ad’a, a partire dagli esordi nel 2003, si è formato sulle ibridazioni linguistiche e sugli sconfinamenti dei linguaggi e delle tecniche, intra ed extra moenia, dove lo spazio pubblico e la città, i musei e i non luoghi, le forme di relazione e la vita sociale, gli interstizi ambientali e le condizioni antropologiche e culturali, sono la dimensione primaria e privilegiata dell’azione artistica. E da questa non solo apparente fuga dai modelli canonici ha inteso registrare e testimoniare differenti forme di produzione e di (rap)presentazione. In modo tale da confrontarsi con le identità multiple e variegate che sono implicite nella distribuzione dei ruoli interni ed esterni al sistema e alla funzione dell’arte che si muove allo “scoperto”. Nell’incertezza e nella baumaniana dimensione “liquida” della nostra società, il linguaggio dell’arte partecipa di un meticciato di forme e di grammatiche in grado di declinare un dialogo a piu voci con i saperi specialistici. E da tali pratiche e comportamenti condivisi e messi a disposizione, non si può non rilevare un’occasione da non perdere e da non trascurare soprattutto nei riquadri di un risvolto “pubblico” e di partecipazione relazionata ai valori di tradizioni e di memorie, di risonanze e di “continuità” tra passato, presente e futuro.
+ l, 2012
“Da quando si è trasferito a Milano ha preso una specie di abitudine, lui la chiama fare ginnastica, ginnastica degli occhi e della mente: si alza presto la mattina, nelle giornate serene, ed esce in bici- cletta. Attraversa pedalando le mille geometrie di luce e ombra sull’asfalto, perfettamente disegnate in quell’ora, e raggiunge una sua meta; oggi è il video Via Dolorosa di Mark Wallinger, in Duomo. Lega la bicicletta al parapetto della metropolitana, a passo svelto sale i gradini del Sagrato ed entra in Duomo prima dell’arrivo dei turisti. Percorre spedito la navata di destra, scende nella cripta e qui, seduto su una panca, guarda, da solo, l’opera di Mark Wallinger.
Cerca nella cornice delle immagini un segno che possa essere il segnale del suo personale loop.
E guarda.
Guarda per diversi minuti questo rettangolo nero che nasconde i sette ottavi dello schermo.
Non pensa a niente.
Nero, nero assoluto. Uno sbarramento, un ostacolo che impedisce la visione.
Guarda per diversi minuti questo rettangolo nero e vede la sfocatura dei bordi. Una sfumatura infinitesimale che unisce questo all’immagine che nasconde, e ne fa una cosa sola.
E la guarda.
La guarda per diversi minuti e non pensa a niente, fino al segnale del suo personale loop nelle immagini della cornice.
Dopo aver guardato, da solo, l’opera di Mark Wallinger, si gira scavalcando la panca su cui era seduto e sale spedito le scale della cripta, percorre la navata di destra ed esce dal Duomo mentre entra un gruppo di turisti. Scende a passo svelto gli scalini del Sagrato e slega la bicicletta dal parapetto della metropolitana.
Oggi la sua meta è stata il video Via Dolorosa di Mark Wallingher, in
Duomo.
Ora pedala attraversando le diverse geometrie della luce e dell’ombra disegnate sull’asfalto nelle mezze mattine di una giornata serena, e ritorna. Ritorna, in bicicletta, da quella sua abitudine che lui chiama fare ginnastica, ginnastica dell’occhio e della mente, che ha preso da quando si è trasferito a Milano”.
Alessandro Sarri, VERBATIM, 2011
Galleria Enrico Fornello, Milano
Catalogo MiArt, Silvana Editoriale, Milano, 2011
La tautologia della cancellatura intesa qui come la rovina anticipata di matrice mai incarnata. Ciò investe necessariamente lo statuto di una traccia che continua a apparire nonostante la cancellatura e continua a sparire nonostante l’apparizione. Potremmo chiederci che tipo di sguardo necessita questa sorta di traccia che continua a tracciare la propria immobilità. Infatti, che tipo di traccia è una traccia che continua a sventarsi attraverso una traccia che non di-venterà mai una traccia? Si può ancora parlare di traccia? E’ mai stata una traccia? Si è mai promessa ad una traccia che potrà cosi approcciarsi ad un qualche tipo di traccia? Questa traccia è una metafora di qualcosa o, in questo caso, la metafora è ‘solo’ la metafora incagliata di sé? Per questa ragione qui potremmo cercare di approcciare la nozione di metafora morta. Questa metafora è un qualcosa che ha smarrito tutte le connessioni da una causa che innescherebbe necessariamente ogni sorta di protesi o innesto, una metafora lontana dal farsi tumulare in un’ermeneutica del palinsesto intesa come qualcosa da riattivare attraverso una ritenzione in tempo reale concepita espressamente per coprire ciò che non potrà mai essere una ritenzione. Questa metafora bloccata balbetta una metafora che annienta ogni metafora. Forse potremmo parlare di qualcosa incapace di assorbire la condizione della propria perdita, qualcosa che rilascia una ritenzione forclusa che nessuna ritenzione riuscirà mai a ritenere. Una ritenzione che s’invalida attraverso un proprio che minaccia e infesta ogni proprietà. Questo è forse ciò che intendiamo qui per tautologia della cancellazione: una traccia barrata di una meta-fora irreversibile che non cessa mai di ripetere la propria ripetizione impossibile, in altre parole, l’inerzia atarassica che permette il rigetto primario del proprio senso irrevocabile. Un senso che perciò non ha senso ma, in questo caso, solo il suo senso. Qualcosa che cancella la propria presenza mediante una presenza che erode i margini della propria non—proprietà. Questa cancellatura sembra un’autosoppressione in una presenza che non sarà mai al suo posto perché sarà sempre stata qui, nella cancellatura indelebile che sventa sia la presenza che l’assenza. Una metafora che non sa niente di sé in ragione dell’indicibile segregazione del proprio noumeno, una metafora incapace di riconoscersi mediante gli stratagemmi inetonirnici che inseguono e intrappolano il proprio indimostrabile soliloquio nel porto sicuro di un avvicendamento significante incaricato di seppellire questo grumo anasemico mediante una sutura a venire di un’opzione o soluzione supplementare.
Alessandro Sarri, VERBATIM, 2011
Enrico Fornello Gallery, Milan
MiArt catalogue, Silvana Editoriale, Milan, 2011
The tautology of the erasure intended here as the anticipated ruin of a never embodied matrix. This necessarily involves the status of a trace that keeps on appearing in spite of an erasure and keeps on disappearing in spite of an appearance.We could ask ourselves what kind of gaze we need just to be able to face this sort of trace that keeps on tracing its stillness. In fact, what kind of trace is a trace that never stops foiling itself through a trace that will never become a trace. Is it still a trace? Has it ever been a trace? Has it ever been promised itself to a trace that will be able to approach to some kind of trace? Is this trace a metaphor of something or, in this case, the metaphor is ‘only’ the hampered metaphor of itself? For this reason we could try to approach here the notion of dead metaphor. This metaphor is something that lost all the links from a cause that unavoidably could trigger any kind of prosthesis or graft, a metaphor far from being entombed in an hermeneutics of the palimpsest intended as something that has to be reenacted through a simultaneous retention expressly conceived to cover what will never to able to be retained. This blocked metaphor stammers a metaphor without metaphor that annihilates every metaphor. Maybe we could talk about something incapable to absorb the condition of its loss, something that relapses a kind of forcluded retention that no retention will ever be able to retain. A retention that invalidates itself through a proper that threatens and haunts every property. This is perhaps what we intend here as the tautology of the erasure: a barred trace of a not reversible metaphor that never stops repeat-ing its impossibile repetition, in other words, the atarassic inertia that enables the primal rejection of its irrevocable sense. A sense that therefore makes no sense but only, if that is the case, its only sense. Something that erases its presence through a presence that erodes the margins of its non-property. This erasure seems like a self suppression in a presence, a presence that will never be there because it will have always been here, in the indelible erasure that foils both the presence and the absence. A metaphor that does not know anything about itself because of the unutterable segregation of its nouomenon, a metaphor incapable to recognize itself through the trick of a metonomy that tracks and traps its indemonstrable soliloquy in the safe harbour of a shifting signifier, charged to bury this an asemic clot through a postponed suture of a supplementary option and solution.
Chiara Agnello, OUVERTURE, Flash Art n278, 2009
Senza Titolo (Oggetti dipinti) (2009) segna ad oggi uno dei passaggi più poetici del percorso di Giovanni Oberti: conservata in una teca di vetro come un raro cimelio, un’arancia modellata dal tempo diventa una preziosa scultura dipinta. Essiccata e ricoperta di grafite, quasi protetta da una pesante patina di bronzo, sembra avere una seconda pelle. Attraverso segni raffinati, silenziosi e precisi, Oberti ci ricorda quanto la valutazione di cose o situazioni non possa essere ridotta semplicemente alla loro superficie.
Il percorso artistico del giovane artista di origine bergamasca procede tra oggetti che hanno catturato la sua attenzione e luoghi di cui ha fatto esperienza. I suoi racconti indagano la quotidianità con interventi che vanno dal togliere all’aggiungere, dallo sfocare al concentrarsi su quello che esiste negli interstizi a margine delle azioni principali. Come un sottile filo rosso, emerge dalle sue opere il tentativo di dare forma al tempo stratificato della memoria e alla vita delle cose comuni, sempre risolto con un’economia di gesti: poggia a terra una pietra in granito raccolta per le strade di Gésteborg, simbolo di costruzione e distruzione per essere stata usata più volte come arma durante manifestazioni; investe il budget messo a disposizione da un’agenzia di comunicazione — per la realizzazione di un’opera — nella creazione di un foglio d’oro formato A4; nasconde nel muro di una galleria un chiodo d’oro lungo 12 cm di cui si intravede solo la capocchia sporgente. Al centro della sua attuale ricerca è il lampadario ready-made trovato nella sua prima casa milanese, poi spostato di volta in volta nelle case abitate (Senza Titolo. Simultaneità di luoghi, di tutti i paesi che sappiamo… , 2008). Segnato dal lento stratificarsi della polvere, l’oggetto sembra conservare memoria di tutti i luoghi in cui è stato usato. Allo stesso modo in Senza Titolo (Forks, Dust) (2006-2008) la polvere racconta il tempo delle cose, quasi a svelarne la cronologia, e conserva le tracce del processo che l’ha determinata, creando un cortocircuito fra presente, passato e memoria, come sottolinea Elio Grazioli nel saggio La polvere nell’arte. Si tratta di un intervento realizzato nella sala da pranzo barocca di Palazzo Tozzoni di Imola. Dal tavolo riccamente apparecchiato, Oberti rimuove le stoviglie, creando un gioco di impronte che trasforma l’assenza in presenza; sui mobili e sulle credenze dispone invece la propria collezione di forchette raccolte nel corso degli anni.
Anche attraverso il video e la fotografia, Giovanni Oberti persegue l’obiettivo di carpire il tempo delle cose, la loro cronologia interna, la relazione con gli elementi vicini. Nelle quattro fotografie polaroid di Senza Titolo (Polaroid Muri Chiostro S. Agostino, BG) (2007), “ferma” il vissuto del luogo prima che la ristrutturazione ne cancelli tracce e ricordi.
La foto — scatto unico e irripetibile in quanto polaroid — diviene una fessura temporale, un archivio d’emozioni. Così come in Tra spettatore e superficie (Sposalizio della Vergine) (2008) registra per qualche minuto, con inquadratura fissa, una delle più note rappresentazioni prospettiche rinascimentali, mettendo a fuoco la distanza tra lo spettatore e il quadro. Ne risulta un video dalle immagini sfuocate, che racconta non tanto il celebre dipinto di Raffaello, quanto piuttosto lo spazio in cui l’opera si trova, in continuo dialogo con gli elementi visivi e sonori circostanti. Come nel caso di Palazzo Tozzoni il vuoto e l’assenza si trasformano in presenza.
A volte il meccanismo è più semplice e per immergere spettatore e opera in un continuo divenire, all’artista basta imbiancare la vetrina dello spazio espositivo (Senza titolo. Pittura, bianco pieno, 2009), come si è soliti vedere nei locali sfitti: la pittura stratificata ricopre a pennellate grossolane il lato esterno del vetro, quello esposto all’azione della pioggia e di eventuali passanti, forse curiosi di scrutare oltre la superficie. All’interno l’atmosfera è straniante e sospesa in una dimensione di pura contemplazione, dove ogni elemento emana la propria aurea.

Senza Titolo (Oggetti dipinti),2009
Arancia disidratata, grafite, teca in cristallo
Dimensioni Variabili
Fotografia Floriana Giacinti
Collezione privata, New York
Untitled (Painted object), 2009
Dry orange, graphite, crystal case
Variable dimensions
Photo Floriana Giacinti
Private collection, New York
Stefano Romano, FUNZIONI CONTINUE, progetti senza soluzione di continuità, 2010
La topologia o studio dei luoghi (dal greco ToTrog, luogo, e Aoyos, studio) è una delle più importanti branche della ma-tematica moderna. Si caratterizza come lo studio delle proprietà delle figure e delle forme che non cambiano quando viene effettuata una deformazione senza “strappi”, “sovrapposizioni” “incollature”.
La topologia si basa essenzialmente sui concetti dì spazio topologico, funzione continua e omeomorfismo. Col termine topologia si indica anche la collezione di aperti che definisce uno spazio topologico. Per esempio un cubo e una sfera sono oggetti topologicamente equivalenti (cioè omeomorfi), perché possono essere deformati l’uno nell’altro senza ricorrere a nessuna Incollatura, strappo o sovrapposizione.
Un esempio di oggetto topologico è il nastro di Mbbìus (dal nome del matematico tedesco August Ferdinand labius).
Le superfici ordinarie, intese come le superfici che nella vita quotidiana siamo abituati ad osservare, hanno sempre due “lati” (o meglio, facce), per cui è sempre possibile percorrere idealmente uno dei due lati senza mai raggiungere il secondo, salvo attraversando una possibile linea di demarcazione costituita da uno spigolo (chiamata “bordo”): si pensi ad esempio alla sfera, al toro, o al cilindro. Per queste superfici è possibile stabilire convenzionalmente un lato “superiore” o “inferiore”, oppure “interno” o “esterno”.
Nel caso del nastro di MÓbius, invece, tale principio viene a mancare: esiste un solo Iato e un solo bordo. Dopo aver percorso un giro, ci si trova dalla parte opposta. Solo dopo averne percorsi due ci ritroviamo sul lato iniziale. Quindi per esempio una formica potrebbe passare da una superficie a quella “dietro”, senza attraversare il nastro e senza saltare il bordo, semplicemente camminando abbastanza lontano.
Manuel Scano, 2009
Catalogo Il raccolto d’autunno è stato abbondante, Mousse Publishing, Milan, 2011
Consideriamo ora taluni passi scientifici contenuti nell’opera in versi e in prosa di Dante. Per affermare, secondo i principi della scienza del tempo, che la facoltà visiva corre incontro allo stimolo luminoso, il poeta si serve di un’efficace rappresentazione; egli descrive infatti la scena dell’incontro tra la luce che giunge nell’occhio passando di membrana (gonna, nell’accezione medica del tempo) e la facoltà visiva che le si fa incontro, provocando lo svegliarsi (sí disonna) del soggetto: e come a lume acuto si disonna per lo spirito visivo che ricorre a lo splendor che va di gonna in gonna
Bianca Trevisan, 2020
AUTOBIOGRAFIA DI RIFLESSI E POLVERE
Un approccio sottile. Vagando per le stanze dell’Ateneo di Palazzo Tosio, la sensazione è che Giovanni Oberti abbia appoggiato delicatamente le sue opere senza spostare nulla, mostrando il rispetto che solo l’ospite più educato ha verso il luogo in cui si trova.
Questa sottigliezza risuona non solo in tutto il suo lavoro artistico, ma anche nella sua persona, nel suo stare nel mondo. Sottile deve la sua etimologia al latino subtīlis, aggettivo originariamente usato dai tessitori per riferirsi a ciò che passa sotto l’ordito, ciò che è sottostante alla tela. Tale termine rispecchia il lavoro di Oberti in senso duplice: il primo ha a che vedere con la levità, la grazia di ogni suo intervento; il secondo con il nascondimento, “trovarsi sotto” nel senso di non mostrarsi subito ma gradualmente e solo a chi voglia vedere davvero. Oltre la superficie, potremmo dire, oltre la “pelle degli oggetti”, si nasconde la vera essenza del visibile. Ecco allora i suoi semi e piccoli frutti essiccati e ricoperti da un – appunto – sottile strato di grafite, steso, disegnato con la matita pazientemente, non fissato perché restituito al decadimento originario dovuto al tempo che inesorabilmente passa, come quello delle nostre esistenze. Ritornare alla natura è un atto di consapevolezza del proprio essere solo una minuscola parte dell’universo e in questo stare umilmente, senza pretendere un’eternità inevitabilmente utopica.
Il tempo, poi, è una condizione essenziale della ricerca di Oberti: “tutto per me ha a che fare con ciò che viaggia velocissimo all’interno delle nostre vite”, afferma, e tale fuggevolezza lo porta al tentativo di registrazione delle sue tracce. La “patina” di grafite, che lentamente decade dalla superficie sulla quale è stata applicata, riproduce al contrario quella della polvere, che altrettanto lentamente si deposita su quella stessa superficie. Questi piccoli frutti monocromatici sono inaspettatamente diversi rispetto al loro aspetto abituale, sembrano pietrificati ma conservano la loro marcescenza: paiono altro da sé, ingannano lo spettatore ma non per un senso di ribaltamento carnevalesco, ma per richiamarlo e portarlo a vedere meglio, a vedere davvero, ad avvicinarsi alla verità che è ben oltre la superficie.
Tale penetrazione visiva è da ricollegarsi anche alla voluta artificialità della scelta monocromatica; se negli achromes di Piero Manzoni “la superficie dimostra la sua capacità di chiusura ad ogni altro significato”, salvandosi dalla contingenza delle relazioni con l’esterno, giungendo quindi ad una “superficialità totale”, qui accade l’opposto: la superficie è un invito ad un approccio ulteriore, a squarciare il suo velo per accedere ad una verità che è lasciata nelle libere mani dello spettatore. Lo strato di grafite, dunque, “illude l’occhio dell’osservatore creando una seconda superficie, bloccando al suo interno la scultura […] raccontandoci come la rappresentazione non possa essere ridotta alla sola superficie, e la considerazione di un oggetto non possa essere ridotta solo a ciò che è visibile”.
A fare eco agli oggetti dipinti sono i calici, qui esposti elegantemente sui tavoli delle stanze dell’Ateneo, ricordo fittizio e al contempo evocativo di chi ha abitato questi luoghi. La “patina” qui è data dal calcare depositato nei bicchieri ottenuto dal paziente gesto dell’artista che per mesi, quotidianamente, ha lasciato decantare e girare l’acqua al loro interno. Lo strato che ricopre la superficie ne impedisce la trasparenza e a differenza delle tracce di grafite è bianca, opaca, all’interno dell’oggetto, volta ad evidenziare null’altro che il vuoto infrasottile che abita e compone i bicchieri. Nulla è eterno, e presto quella stessa traccia calcarea si decomporrà restituendo una “pittura del tempo” non solo attraverso la sedimentazione, ma anche attraverso il suo stesso decadimento.
L’essenzialità del linguaggio di Oberti si riflette nelle sue scelte minime, ma decise. Uno dei due tavoli in questa mostra ospita una singola coppia di calici, che paiono guardarsi in un dialogo congelato, sospeso. Sembrano identici, ma un’attenta osservazione rivela che sono soltanto simili: la dualità e l’impossibilità dell’uguale sono altre tematiche fondamentali nel suo lavoro. Tale impossibilità è evidente anche negli specchi, girati contro il muro e ricoperti di grafite. Lacan ne Lo stadio dello specchio cita Seneca “specula […] seducunt imagines suas”: la formazione dell’io passa attraverso il rispecchiamento, attraverso la percezione di se stessi come alterità per poi riconoscersi. Ma ciò che vediamo nello specchio è una realtà parziale, sottoposta al rischio della pietrificazione dello sguardo di Medusa, che colpisce l’osservatore sottraendolo allo scorrere del tempo. Ricoprire dunque la superficie è un rifuggire dall’equivoco, sottrarsi dall’illusione dell’eternità, ponendo una distanza tra spettatore e superficie. La distanza infatti è una condizione irrimediabile, ma l’artista richiede di indagare anche quel vuoto, lo spazio invisibile tra noi e ciò che stiamo guardando. Accade anche per i piccoli nidi di vespe appesi ai soffitti: guardarli “è come osservare un pozzo al contrario”, richiedono uno sforzo visivo perché chi osserva è richiamato dal mistero dei loro piccoli fori, che rimangono imperscrutabili. Mistero, dialoghi impossibili, inattuabilità dell’ontologicamente uguale: ci si può incontrare solo nella consapevolezza di questo limite come accade in un rapporto d’amore.
Un gesto d’amore è anche la scelta dei suoi oggetti, determinata spesso dalla loro rarità o dal loro potenziale affettivo: ad esempio semi particolari come quello del banano di montagna, nocciole gemelle, vecchi specchi trovati da rigattieri o in case di campagna, piccoli alveari, bicchieri regalati da amici, ospiti e commensali. “Quando una cosa è rara la ami di più”, afferma l’artista, al quale piace ricollegarsi agli “oggetti d’affezione” di Man Ray. Le sue opere sono infatti sempre frutto di una ricerca volta alla rarità, ma una rarità piccola, intima e, appunto, affettiva, attenta al punctum che sollecita “l’occhio che pensa” dello spettatore, facendo scaturire una “forza di espansione” che può dipanarsi nelle più soggettive direzioni. Così agiscono anche i due tronchi di palma che troneggiano solitari nella Cappella: sembrano legname da camino ma non lo sono in quanto la loro elevata densità ha un livello di combustione molto basso. Ancora l’equivoco, alimentato da due piccoli merletti di pizzo che fanno sembrare quei tronchi due gambe ammiccanti.
L’umanizzazione riporta nuovamente al legame uomo-natura e ai cicli naturali: non si tratta di fatalismo, ma di tornare alla durata alla quale apparteniamo e da cui non possiamo prescindere. La sottigliezza di Oberti è qui, nell’aderire alle cose superando l’ordito della loro superficie, andando a fondo. Oltre il visibile, soggiace la verità umbratile delle nostre esistenze: non ci resta che coglierla, se vorremo, in un processo lieve e soggettivo, lento, abitatore del tempo che è nostro e, insieme, universale.
1 Il riferimento è al titolo di una mostra tenutasi alla Galleria Milano lo scorso anno, si veda: Elio Grazioli, Bianca Trevisan, Giovanni Oberti. La pelle degli oggetti, catalogo della mostra (Milano, Galleria Milano, ottobre-dicembre 2019), Lubrina Bramani Editore, Bergamo 2019.
2 Senza titolo (Oggetti dipinti), 2009-2015.
3 Da una conversazione di chi scrive con l’autore, Milano, 1° settembre 2020.
4 Chiara Dezzi Bardeschi (a cura di), Abbeccedario minimo ‘ananke. Cento voci per il restauro, Altralinea, Firenze 2017.
5 Germano Celant, Piero Manzoni, catalogo generale, Prearo Editore, Milano 1975, p. 34.
6 Ibidem.
7 Oberti su https://www.juliet-artmagazine.com/.
8 Archi di dama, 2013.
9 Elio Grazioli parla del lavoro di Giovanni Oberti nel suo Elio Grazioli, Infrasottile. L’arte contemporanea ai limiti, Postmedia books, Milano 2018, pp. 185-187. Qui leggiamo che gli oggetti di Oberti “è […] questo vuoto che mostrano, questa assenza che ora si riempie del nostro sguardo” (p. 187).
10 Oberti in Matilde Galletti (a cura di), Giovanni Oberti. I muri sentono l’amore e la rabbia, ma anche la solitudine e la malattia. Non sanno cos’è la musica, la ripetono, catalogo della mostra (Fermo, Palazzo Brancadoro, 11 luglio-11 agosto 2020), Karussell/arte contemporanea, Fermo 2020, s.p.
11 Qui in mostra Senza titolo (Oggetti dipinti), 2019.
12 Lacan tiene la conferenza Lo Stadio dello Specchio nel 1936 in occasione di un congresso a Marienband della International Psycho-analytic Assosiation. Sebbene una buona parte di questa trattazione sia avvenuta per via orale, oggi è riportata parzialmente in J. Lacan, Scritti, trad. it. Einaudi, Torino 1974.
13 Tra spettatore e superficie (Sposalizio della Vergine) è anche il titolo di un video realizzato nel 2008 dall’artista nella Pinacoteca di Brera, si veda: https://www.youtube.com/watch?v=bVcfRW5W7Gc (ultima consultazione 9 settembre 2020).
14 Gea (La sensazione che si prova guardando il cielo buio, su una canoa in mezzo al mare), 2018 e Gea (Quel freddo buio e senza vento), 2018.
15 Da una conversazione di chi scrive con l’artista, 1° settembre 2020.
16 Man Ray, Oggetti d’affezione, trad. it. Einaudi, Torino 1970.
17 Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia (1980), Einaudi, Torino, 2003, p. 47.
18 Senza titolo (Autoreggenti), 2020.